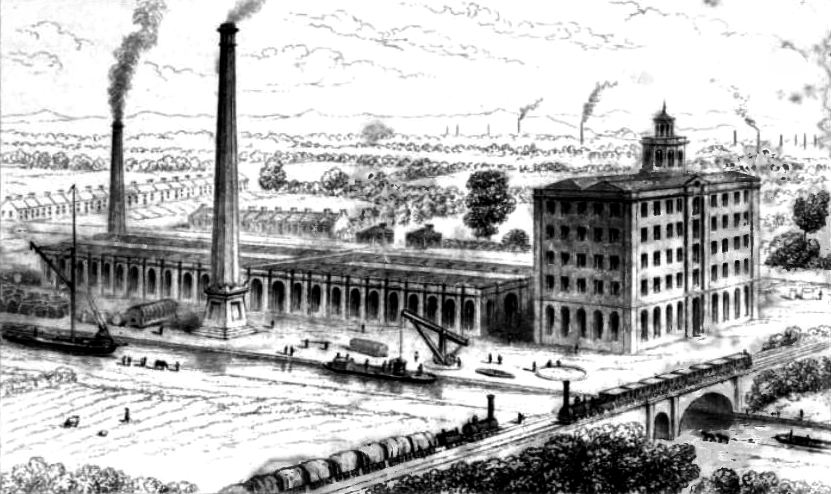(Scrissi questa riflessione nel 2011, e probabilmente è ancora attuale)
La crisi delle economie che fanno parte dell’Euro sembra stia minando l’esistenza stessa dell’Unione Europea.
Non c’è dubbio che l’esperimento dell’Euro sia stato portato avanti in parte con eccessiva arroganza, una arroganza che ha impedito di considerare i rischi che si correvano nell’uniformare certi meccanismi monetari in paesi dal profilo economico molto diverso. D’altra parte, i governi europei e le istituzioni europee hanno troppo a lungo cercato di negare l’evidenza, ostacolando soluzioni tempestive e pregiudicando la fiducia nella loro capacità di intervenire in questa crisi.
Una possibile rottura dell’Unione Europea è diventata una possibilità
che, un tempo impensabile, ora viene discussa apertamente. Quello che
mi stupisce è vedere indipendentisti sardi di vari colori che auspicano o
sembrano auspicare una rottura dell’Unione Europea.
Questo atteggiamento mi lascia perplesso. L’Unione Europea non è certo perfetta e ci sono diversi aspetti del suo funzionamento che andrebbero riveduti e migliorati (per es. la sua trasparenza).
Tuttavia non dovremmo dimenticare quello che l’Unione Europea ha
significato in questi ultimi decenni per la prosperità, la pace, e lo
sviluppo sociale ed economico dell’Europa. E soprattutto, non dovremmo
dimenticare che se oggi possiamo concretamente pensare che piccole nazioni possano diventare stati indipendenti lo dobbiamo soprattutto all’Unione Europea.
Se oggi possiamo considerare che una piccola nazione come la Scozia o la Sardegna
possa diventare indipendente e non solo sopravvivere, ma possibilmente
diventare prospera tanto da garantire un tenore di vita dignitoso ai
suoi cittadini, questo lo dobbiamo al fatto che l’Unione Europea
fornisce una struttura che garantisce sicurezza e l’accesso a mercati per i propri prodotti.
Mentre queste funzioni, difesa e commercio, erano appannaggio degli
stati, con l’Unione Europea queste funzioni sono passate alla struttura
sovra-statuale. Significa quindi che una piccola nazione come la Scozia
non ha bisogno della potenza inglese per difendersi o per poter
garantire scambi commerciali con altri paesi, perché difesa e commercio
sono garantiti dall’Unione Europea.
Se molte nazioni in Europa si avvicinano all’indipendenza (Scozia, Catalogna, Fiandre), questo è anche perché, come sostiene Adam Price, piccoli stati godono di diversi vantaggi economici
rispetto a grossi stati che fanno parte dell’Unione Europea. Tra le
ragioni di questo vantaggio ci sarebbe la possibilità di piccoli stati
che si specializzano in alcuni settori di raggiungere mercati più ampi
dove esportare, e l’esportazione produce ricchezza. Adam Price parla
apertamente di “benefici” dell’indipendenza (benefici che ovviamente non sono automatici, ma si realizzano se un piccolo stato fa le mosse giuste).
È probabilmente anche significativo che piccole nazioni (per es.
Slovenia, Repubblica Ceca e Slovacchia, il Montenegro) diventino
indipendenti con la prospettiva di entrare nell’Unione Europea: ovvero,
l’esistenza dell’Unione sembra essere stata in molti casi un fattore che
ha istigato o accelerato il processo di indipendenza.
Ci sarebbe poi da considerare la pace che l’Unione
Europea ha contribuito a mantenere nell’Europa che era stata devastata
da due conflitti mondiali e altri conflitti durante la prima metà del XX
secolo (per es. la guerra civile in Spagna).
Ci sarebbe da considerare il fatto che i cittadini europei godono degli stessi diritti
in tutti i paesi dell’Unione, e che i principi e valori sanciti dai
documenti dell’Unione (per es. la Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo) hanno garantito diritti basilari in
paesi dove questi diritti erano stati soppressi per lunghi periodi
storici (vedi i regimi comunisti in paesi come l’Ungheria e la
Cecoslovacchia).
Ci sarebbe da considerare il fatto che l’Unione Europea garantisce
programmi di scambio negli studi, permettendo a studenti europei di
formarsi in altri paesi, e finanzia collaborazioni nella ricerca tra i
paesi europei, contribuendo all’innovazione e lo scambio di conoscenze
in vari paesi.
Infine ci sarebbe da considerare quanto l’Unione Europea ha fatto e fa per cercare di colmare il divario infrastrutturale ed economico in varie regioni.
Certamente l’Unione Europea non è perfetta, e la crisi economica sta
mettendo a dura prova il suo funzionamento. Tuttavia una sua rottura
potrebbe riportare l’Europa in uno scenario molto più instabile, uno scenario dove l’indipendenza di piccole nazioni potrebbe non essere più così facilmente pensabile, né praticabile.

gittinwide blog by Oliver Perra is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
La mancanza di un orizzonte: il problema dell'educazione in Sardegna
Piuttosto regolarmente in Sardegna si ripetono gli allarmi per l'alto livello di abbandono scolastico in Sardegna (vedi qua e qua per esempio).
Quello che i giornali sardi non sembrano in grado di fare è dare una lettura dei dati che vada al di là dell'immediato e del sensazionale. Basterebbe usare dati facilmente reperibili in in rete per rendersi conto che questi allarmi sull'abbandono scolastico nel 2014 sono solo un ripetersi di un problema che in Sardegna è presente da molto tempo; un problema a cui nessuno (la politica sarda prima di tutti) sembra potere o voler risolvere.
Si può considerare per esempio quanti giovani abbandonano l'educazione e la formazione usando dati forniti da Eurostat, l'ufficio statistico europeo. Il grafico qua sotto mostra come la percentuale di giovani tra i 18 e i 24 anni in questa situazione in Sardegna sia più alta rispetto alla media italiana, e molto più alta rispetto alla media europea (considerando i 27 stati dell'EU fino al 2013). Ma non solo, si nota anche che, mentre la percentuale di giovani che abbandonavano la formazione era in calo tra il 2010 e il 2007 (seppure con notevoli variazioni di anno in anno), questo calo sembra essersi arrestato. Un quarto (25%) dei giovani tra i 18 e i 24 anni abbandona l'educazione o la formazione con un titolo di educazione secondaria superiore o meno. Anche se metodologicamente è una forzatura confrontare i dati regionali con quelli nazionali e sovra-nazionali, possiamo invece vedere qua sotto come la media italiana dell'abbandono scolastico sia in continuo calo in Italia e nell'EU.
L'abbandono della formazione tra i 18 e i 24 anni potrebbe non essere un fatto del tutto negativo se i giovani che abbandonano la formazione trovassero una occupazione. In Sardegna sappiamo bene che questo non è quello che accade. E infatti. le statistiche europee confermano che c'è un'alta percentuale (oltre il 25%) di giovani tra i 15 e i 24 anni che pur abbandonando la formazione non sono occupati, come indicato nel grafico qua sotto. Anche qua si può notare come dal 2008 in poi la tendenza si inverte e si assiste a un aumento dei giovani che non sono né in occupazione né in formazione. La crisi economica potrebbe spiegare questo peggioramento delle condizioni di molti giovani. Rimane il fatto che si assiste al peggioramento di un problema in Sardegna.
L'abbandono della formazione da parte dei giovani si ripercuote anche sulla percentuale di studenti nell'istruzione terziaria, ovvero a livello universitario. La Sardegna ha una bassa percentuale di giovani che studiano all'università rispetto alla media italiana ed europea, come il grafico qui sotto mostra. Ancora una volta, si nota come dal 2008 in poi ogni segno di miglioramento si arresta del tutto in Sardegna.
Questo problema ha due aspetti importanti:
Il primo è quello dei diritti e della partecipazione sociale. I giovani che abbandonano l'educazione e la formazione sono presumibilmente giovani che in diversi casi non hanno ricevuto gli strumenti culturali necessari per poter partecipare pienamente alla società. Potrebbero infatti essere giovani che non hanno piena conoscenza dei loro diritti o di come attuarli.
Inoltre, l'abbandono degli studi si associa a ridotte prospettive di occupazione e di guadagno. In altre parole, questi giovani sono a maggior rischio di esclusione sociale.
D'altra parte c'è l'aspetto economico: una cittadinanza meno formata ha meno possibilità di contribuire all'economia, in particolare quando il successo economico di una nazione in Europa si basa sempre più sulle capacità di innovare e rapportarsi al resto del continente e oltre.
Dato questo quadro, cosa fa la politica sarda? Molto poco. Per esempio, uno studio che aveva valutato l'impatto di alcuni laboratori tematici forniti in alcune scuole per "superare la lezione tradizionale", concludeva che questi laboratori non avevano praticamente nessun impatto di rilievo sui risultati che avrebbero dovuto contribuire a migliorare. Nonostante tutte le cautele necessarie nel valutare una singola ricerca, con i suoi limiti, questa ricerca sembra indicare che uno degli interventi attuati dalla politica non sembra funzionare. Questo è preoccupante quando si considera che, in una situazione dove risorse economiche e umane sono limitate, questi programmi spendono risorse senza produrre effetti.
In questo quadro poi si inserisce il continuo sgretolarsi delle risorse per la scuola e l'educazione, come per esempio l'annuncio della chiusura di diverse scuole in paesi della Sardegna.
Il problema maggiore è che sembra mancare un riconoscimento della gravità del problema da diverse parti (inclusi i cittadini sardi). Ma soprattutto, la politica sarda si dimostra incapace di attuare politiche per il futuro, di avere un orizzonte per il domani, ma solo preoccupata a gestire il presente. Il moto della politica sarda sembra del resto essere, da diversi anni, "No future...for you".
Quello che i giornali sardi non sembrano in grado di fare è dare una lettura dei dati che vada al di là dell'immediato e del sensazionale. Basterebbe usare dati facilmente reperibili in in rete per rendersi conto che questi allarmi sull'abbandono scolastico nel 2014 sono solo un ripetersi di un problema che in Sardegna è presente da molto tempo; un problema a cui nessuno (la politica sarda prima di tutti) sembra potere o voler risolvere.
Si può considerare per esempio quanti giovani abbandonano l'educazione e la formazione usando dati forniti da Eurostat, l'ufficio statistico europeo. Il grafico qua sotto mostra come la percentuale di giovani tra i 18 e i 24 anni in questa situazione in Sardegna sia più alta rispetto alla media italiana, e molto più alta rispetto alla media europea (considerando i 27 stati dell'EU fino al 2013). Ma non solo, si nota anche che, mentre la percentuale di giovani che abbandonavano la formazione era in calo tra il 2010 e il 2007 (seppure con notevoli variazioni di anno in anno), questo calo sembra essersi arrestato. Un quarto (25%) dei giovani tra i 18 e i 24 anni abbandona l'educazione o la formazione con un titolo di educazione secondaria superiore o meno. Anche se metodologicamente è una forzatura confrontare i dati regionali con quelli nazionali e sovra-nazionali, possiamo invece vedere qua sotto come la media italiana dell'abbandono scolastico sia in continuo calo in Italia e nell'EU.
L'abbandono della formazione tra i 18 e i 24 anni potrebbe non essere un fatto del tutto negativo se i giovani che abbandonano la formazione trovassero una occupazione. In Sardegna sappiamo bene che questo non è quello che accade. E infatti. le statistiche europee confermano che c'è un'alta percentuale (oltre il 25%) di giovani tra i 15 e i 24 anni che pur abbandonando la formazione non sono occupati, come indicato nel grafico qua sotto. Anche qua si può notare come dal 2008 in poi la tendenza si inverte e si assiste a un aumento dei giovani che non sono né in occupazione né in formazione. La crisi economica potrebbe spiegare questo peggioramento delle condizioni di molti giovani. Rimane il fatto che si assiste al peggioramento di un problema in Sardegna.
L'abbandono della formazione da parte dei giovani si ripercuote anche sulla percentuale di studenti nell'istruzione terziaria, ovvero a livello universitario. La Sardegna ha una bassa percentuale di giovani che studiano all'università rispetto alla media italiana ed europea, come il grafico qui sotto mostra. Ancora una volta, si nota come dal 2008 in poi ogni segno di miglioramento si arresta del tutto in Sardegna.
Questo problema ha due aspetti importanti:
Il primo è quello dei diritti e della partecipazione sociale. I giovani che abbandonano l'educazione e la formazione sono presumibilmente giovani che in diversi casi non hanno ricevuto gli strumenti culturali necessari per poter partecipare pienamente alla società. Potrebbero infatti essere giovani che non hanno piena conoscenza dei loro diritti o di come attuarli.
Inoltre, l'abbandono degli studi si associa a ridotte prospettive di occupazione e di guadagno. In altre parole, questi giovani sono a maggior rischio di esclusione sociale.
D'altra parte c'è l'aspetto economico: una cittadinanza meno formata ha meno possibilità di contribuire all'economia, in particolare quando il successo economico di una nazione in Europa si basa sempre più sulle capacità di innovare e rapportarsi al resto del continente e oltre.
Dato questo quadro, cosa fa la politica sarda? Molto poco. Per esempio, uno studio che aveva valutato l'impatto di alcuni laboratori tematici forniti in alcune scuole per "superare la lezione tradizionale", concludeva che questi laboratori non avevano praticamente nessun impatto di rilievo sui risultati che avrebbero dovuto contribuire a migliorare. Nonostante tutte le cautele necessarie nel valutare una singola ricerca, con i suoi limiti, questa ricerca sembra indicare che uno degli interventi attuati dalla politica non sembra funzionare. Questo è preoccupante quando si considera che, in una situazione dove risorse economiche e umane sono limitate, questi programmi spendono risorse senza produrre effetti.
In questo quadro poi si inserisce il continuo sgretolarsi delle risorse per la scuola e l'educazione, come per esempio l'annuncio della chiusura di diverse scuole in paesi della Sardegna.
Il problema maggiore è che sembra mancare un riconoscimento della gravità del problema da diverse parti (inclusi i cittadini sardi). Ma soprattutto, la politica sarda si dimostra incapace di attuare politiche per il futuro, di avere un orizzonte per il domani, ma solo preoccupata a gestire il presente. Il moto della politica sarda sembra del resto essere, da diversi anni, "No future...for you".
Vittima del proprio successo? I miei dubbi su Sardex
Sardex, la moneta complementare sarda, sembra avere sempre più successo. Che cos'è Sardex è spiegato in altri luoghi, quindi uno può farsi un'idea di come funzioni questo strumento che permette di "monetizzare in beni e servizi i crediti derivati dalle vendite".
Mi fa piacere leggere di una storia di innovazione e successo in Sardegna. Inoltre, in una realtà come quella sarda, dove esiste una cronica mancanza di liquidità, il fatto che le aziende possano continuare a lavorare attraverso questa moneta complementare è un grosso risultato. Infine, penso sia molto positivo il tessuto di scambi che questa moneta complementare incentiva: gli scambi di natura economica sono la base da cui nascono scambi di competenze e di idee, il che potrebbe creare effetti positivi nel lungo termine (per esempio: più aziende che collaborano).
Tuttavia, non posso fare a meno di pensare che esista un rischio quando una moneta che nasce per essere complementare acquista troppi spazi. In questo articolo, per esempio, si dice che impiegati di certe aziende ricevono parte del loro stipendio in Sardex. L'articolo riferisce anche che questa decisione è stata necessaria per salvare l'azienda.
Presumibilmente questi impiegati non hanno avuto molta scelta: o accettavano di vedere parte del loro compenso in Sardex, o era la chiusura. Ma se uno può fare la spesa o andare al ristorante e pagare in Sardex dove sta il problema? Il problema sta nel fatto che, verosimilmente, sempre meno persone avranno la possibilità di risparmiare, e questo significa meno possibilità di fare investimenti per il futuro (comprare una casa, un terreno, ma anche investire in formazione personale, ecc.).
Inoltre, il fatto che impiegati vengano pagati in Sardex che non hanno valore se non scambiati nel circuito, verosimilmente induce queste persone a spendere quei crediti Sardex in beni o servizi che non avrebbero comprato in altre condizioni. Molto bello pensare che con quello stipendio in Sardex posso finalmente permettermi il lusso di una cena in ristorante, meno bello pensare che però magari non sto risparmiando per pagarmi quel corso di formazione che volevo fare, o per investire in una attività collaterale, ecc.
Lo stesso discorso potrebbe applicarsi alle aziende che lavorano nel circuito Sardex: se da complementare, la moneta Sardex diventa dominante, le aziende avranno sempre meno risparmi e liquidità per comprare nuove tecnologie, o per formarsi, ecc.
Alla fin fine, in un sistema che nasce come complementare ma che prende troppi spazi all'altro sistema (sempre più in crisi), il rischio maggiore è quello di creare un sistema economico chiuso in cui aziende e privati si scambiano servizi ma dove hanno sempre meno possibilità di interagire con altri sistemi per mancanza di credito e liquidità.
Questo è un rischio perché un sistema chiuso non ha possibilità di innovarsi tecnologicamente (a meno che il sistema non crei tutta la tecnologia di cui ha bisogno, cosa molto difficile). Questo significa che sarà un sistema inefficiente (aziende che creano prodotti o forniscono servizi costosi e antiquati, e magari venduti solo perché i privati devono in qualche modo usare i loro Sardex). Un sistema del genere diventa vulnerabile a prodotti o servizi provenienti da altri sistemi aperti che forniscono beni e prodotti innovativi, efficienti, e a costi minori.
Senza nulla togliere agli innegabili meriti di Sardex, il mio dubbio è che un sistema simile possa diventare vittima del proprio successo se prende troppo spazio al sistema alternativo che avrebbe dovuto completare, non sostituire.
Mi fa piacere leggere di una storia di innovazione e successo in Sardegna. Inoltre, in una realtà come quella sarda, dove esiste una cronica mancanza di liquidità, il fatto che le aziende possano continuare a lavorare attraverso questa moneta complementare è un grosso risultato. Infine, penso sia molto positivo il tessuto di scambi che questa moneta complementare incentiva: gli scambi di natura economica sono la base da cui nascono scambi di competenze e di idee, il che potrebbe creare effetti positivi nel lungo termine (per esempio: più aziende che collaborano).
Tuttavia, non posso fare a meno di pensare che esista un rischio quando una moneta che nasce per essere complementare acquista troppi spazi. In questo articolo, per esempio, si dice che impiegati di certe aziende ricevono parte del loro stipendio in Sardex. L'articolo riferisce anche che questa decisione è stata necessaria per salvare l'azienda.
Presumibilmente questi impiegati non hanno avuto molta scelta: o accettavano di vedere parte del loro compenso in Sardex, o era la chiusura. Ma se uno può fare la spesa o andare al ristorante e pagare in Sardex dove sta il problema? Il problema sta nel fatto che, verosimilmente, sempre meno persone avranno la possibilità di risparmiare, e questo significa meno possibilità di fare investimenti per il futuro (comprare una casa, un terreno, ma anche investire in formazione personale, ecc.).
Inoltre, il fatto che impiegati vengano pagati in Sardex che non hanno valore se non scambiati nel circuito, verosimilmente induce queste persone a spendere quei crediti Sardex in beni o servizi che non avrebbero comprato in altre condizioni. Molto bello pensare che con quello stipendio in Sardex posso finalmente permettermi il lusso di una cena in ristorante, meno bello pensare che però magari non sto risparmiando per pagarmi quel corso di formazione che volevo fare, o per investire in una attività collaterale, ecc.
Lo stesso discorso potrebbe applicarsi alle aziende che lavorano nel circuito Sardex: se da complementare, la moneta Sardex diventa dominante, le aziende avranno sempre meno risparmi e liquidità per comprare nuove tecnologie, o per formarsi, ecc.
Alla fin fine, in un sistema che nasce come complementare ma che prende troppi spazi all'altro sistema (sempre più in crisi), il rischio maggiore è quello di creare un sistema economico chiuso in cui aziende e privati si scambiano servizi ma dove hanno sempre meno possibilità di interagire con altri sistemi per mancanza di credito e liquidità.
Questo è un rischio perché un sistema chiuso non ha possibilità di innovarsi tecnologicamente (a meno che il sistema non crei tutta la tecnologia di cui ha bisogno, cosa molto difficile). Questo significa che sarà un sistema inefficiente (aziende che creano prodotti o forniscono servizi costosi e antiquati, e magari venduti solo perché i privati devono in qualche modo usare i loro Sardex). Un sistema del genere diventa vulnerabile a prodotti o servizi provenienti da altri sistemi aperti che forniscono beni e prodotti innovativi, efficienti, e a costi minori.
Senza nulla togliere agli innegabili meriti di Sardex, il mio dubbio è che un sistema simile possa diventare vittima del proprio successo se prende troppo spazio al sistema alternativo che avrebbe dovuto completare, non sostituire.
"La miglior reazione è più democrazia e maggiore partecipazione politica"
Gli orribili fatti di Parigi sono difficili da interpretare sotto ogni logica.
Alcuni hanno paragonato questi attentati alle azioni delle Brigate Rosse negli anni '70 in Italia. Eppure, nonostante le similutidini, le Brigate Rosse avevano un disegno politico riconoscibile e con una logica, per quanto perversa e velleitaria. Nel caso degli attentati dei fondamentalisti a Parigi, non è invece riconoscibile un disegno politico logico.
Il paragone che secondo me sarebbe più appropriato per capire questi attentati è quello con gli attentati dell'IRA (Irish Republican Army) durante il conflitto che ha portato alla nascita dello "Stato Libero" in Irlanda tra il 1916 e il 1921.
Durante questo conflitto infatti, l'IRA spesso perpretava attentati che non avevano apparentemente una logica molto precisa: di fatto molti di questi attentati non intaccavano gli interessi militari ed economici britannici.
Tuttavia, quello che questi attentati ottenevano era scatenare una risposta spropositata e indiscriminata da parte delle truppe britanniche. Queste reazioni colpivano molti cittadini irlandesi che non erano coinvolti e, magari, neanche simpatizzanti della causa irlandese repubblicana. Trattare molti cittadini indiscriminatamente come "potenziali terroristi" e punirli per attentati che non avevano commesso o facilitato, non faceva che causare risentimento e odio verso l'apparato di forza britannico e quindi a spingere anche i cittadini neutrali verso la causa dei repubblicani.
In questo senso, la mancanza di auto-controllo e le reazioni indiscriminate e spropositate delle forze britanniche (e la loro stupida prevedebilità), erano il miglior alleato della causa repubblicana irlandese. Uno stato che discrimina una parte dei suoi cittadini e che rinuncia ad applicare la legge, perde inevitabilmente leggittimità.
Gli attentati di Parigi hanno una logica del genere, secondo me: quello che vogliono provocare è una reazione indiscriminata e spropositata che porti molti mussulmani in Francia e in Europa a sentirsi emarginati, bersagli del sospetto e della discriminazione, che li porti a sentirsi alienati dagli ideali civici di democrazia, rispetto per ogni idea e credo, e rispetto della legge, ideali che sono il fondamento della maggior parte dei paesi occidentali.
Per questo penso che a questi orribili fatti i paesi occidentali non debbano rispondere in modo isterico (del tipo: "siamo in guerra"), ma debbano riaffermare i principi di democrazia e rispetto della legge. La risposta migliore dovrebbe essere quella data dal governo Norvegese dopo il massacro perpretato da un estremista di destra:
" [Norway will] stand firm in defending our values, [...] an open, tolerant and inclusive society". "The Norwegian response to violence is more democracy, more openness and greater political participation."
in difesa del...capitalismo
Il capitalismo oggi non gode di buona pubblicità. Parte di questa cattiva fama è del tutto meritata.
Negli ultimi decenni si è assistito ad un accumulo di ricchezza e opportunità nelle mani di pochi, tanto che si parla di una società ristretta e sigillata. A fronte di questo aumento di ricchezza per i pochi eletti, in Occidente si è assistito ad un lento ma inesorabile declino delle condizioni economiche e delle prospettive future di molti, tanto che alcuni hanno definito questa l'epoca delle "prospettive ridotte".
Tuttavia, leggendo diversi autori mi sono fatto l'idea che questo processo non sia necessariamente un tratto distintivo del capitalismo per sè, quanto un tratto del capitalismo neo-liberista che si è affermato dagli anni '80 in poi.
Cosa non funziona nel capitalismo neoliberista?
Un tratto distintivo di questa forma di capitalismo è la flessibilità dei mercati finanziari unita al potere spropositato degli azionisti nelle imprese o nelle aziende. Le due cose sono collegate ma creano un meccanismo perverso. Come? Gli azionisti comprano le azioni di una azienda e ottengono un potere in genere pari al loro pacchetto di azioni. Tuttavia in molte aziende gli azionisti detengono una maggioranza di azioni rispetto agli "stakeholders". Gli stakeholders sono coloro che hanno un interesse diretto nell'azienda: o ci lavorano (gli impiegati), o sono i direttori e i manager, o sono fornitori dell'azienda. Il benessere degli stakeholders dipende dall'azienda: senza l'azienda gli stakeholders non avrebbero lavoro o salario. Gli azionisti, al contrario, sono solo preoccupati di estrarre il maggior profitto possibile dalle azioni che hanno comprato: in un mercato finanziario estremamente fluido, gli azionisti possono rivendere le loro azioni in pochi minuti e "scrollarsi di dosso" l'azienda in fretta.
Dunque gli stakeholders dovrebbero avere particolarmente a cuore l'azienda da cui dipende la loro occupazione, e quindi il loro scopo è che l'azienda abbia successo nel lungo termine. Gli azionisti, invece, hanno l'obiettivo di massimizzare il profitto delle loro azioni in tempi brevi. Nonostante queste diverse prospettive, gli azionisti hanno un maggiore potere nel prendere decisioni cruciali per il futuro di molte aziende.
Questo significa che in molte aziende ogni investimento fatto per il lungo termine sia visto come un costo inutile da chi è interessato a fare un profitto veloce. E infatti molte aziende (per es. le case automobilistiche americane) per lunghi periodi hanno smesso completamente di fare investimenti per il futuro. Nessun investimento in ricerca e nuove tecnologie, per esempio. Nessun investimento nella formazione e qualificazione della forza lavoro. Siccome gli azionisti pensano ad un profitto veloce, si spende preferibilmente in marketing e altre attività del genere che servono a "gonfiare" la visibilità di un'azienda, facendo alzare le sue quotazioni in borsa, e favorendo gli azionisti.
Visto che chi detiene il potere degli investimenti sta pensando al breve termine invece che al futuro, non sorprende poi tanto che si senta spesso parlare di un'epoca di stagnazione tecnologica e della conoscenza. Quando i migliori cervelli in circolazione vengono catturati da Google e spendono il loro tempo a inventare metodi per convincere un utente a cliccare su un banner pubblicitario, è chiaro che c'è un grosso problema.
Tutto questo vuol dire che il capitalismo non funziona? Prima di buttare via tutto e magari abbracciare vaghi e fantasiosi ritorni ad un passato bucolico mai esistito, ci penserei un paio di volte.
Infatti, il capitalismo non è sempre stato il capitalismo neoliberista attuale. Nel periodo del dopoguerra, almeno in occidente, il capitalismo aveva contribuito ad una enorme diffusione di ricchezza e opportunità che furono molto più equamente condivise dai diversi strati delle società. Oppure, il capitalismo realizzato nei paesi scandinavi riesce a unire la spinta al profitto e la tutela della proprietà privata con un sistema che ridistribuisce la ricchezza generata in modo molto equo e offre opportunità universalmente. E ancora, il recente emergere di nuovi poli economici, è probabilmente in parte responsabile per la riduzione della povertà estrema nel mondo. Come sostengono alcuni autori, la proprietà privata dei mezzi di produzione e l'incentivo al profitto - i cardini del capitalismo- possono essere usati con successo ed efficacemente per creare prosperità e opportunità per i più, non solo per i pochi.
Il capitalismo può perciò essere usato per creare ricchezza, innovazione e opportunità diffuse se solo si approntano i giusti strumenti politici per far lavorare il capitalismo per l'interesse generale. Uno di questi strumenti politici potrebbe consistere nel limitare il potere degli azionisti in molte aziende. Per esempio, in Svezia certi pacchetti di azioni in una azienda detengano un peso maggiore nelle decisioni, assicurando in questo modo che i fondatori di molte aziende e i loro eredi, detentori di questi pacchetti, mantengano maggiore potere decisionale. Oppure, in Germania rappresentanti dei dipendenti partecipano e hanno potere di voto nelle decisioni che riguardano molte aziende. Queste misure politiche potrebbero garantire investimenti in innovazione e formazione, creando lavoratori competenti difficilmente rimpiazzabili da lavoratori a basso costo in altri paesi, e creando innovazione tecnologica che, tra le altre cose, permetterebbe il superamento di tecnologie inquinanti.
Il capitalismo del resto ha permesso un acceleramento del progresso tecnologico e della qualità di vita enorme negli ultimi secoli. Cercherei perciò di far ri-funzionare il capitalismo prima di pensare di poterne fare a meno. Parafrasando Joseph Stiglitz che parlava di John Maynard Keynes, magari bisogna "salvare il capitalismo dai capitalisti".
Negli ultimi decenni si è assistito ad un accumulo di ricchezza e opportunità nelle mani di pochi, tanto che si parla di una società ristretta e sigillata. A fronte di questo aumento di ricchezza per i pochi eletti, in Occidente si è assistito ad un lento ma inesorabile declino delle condizioni economiche e delle prospettive future di molti, tanto che alcuni hanno definito questa l'epoca delle "prospettive ridotte".
Tuttavia, leggendo diversi autori mi sono fatto l'idea che questo processo non sia necessariamente un tratto distintivo del capitalismo per sè, quanto un tratto del capitalismo neo-liberista che si è affermato dagli anni '80 in poi.
Cosa non funziona nel capitalismo neoliberista?
Un tratto distintivo di questa forma di capitalismo è la flessibilità dei mercati finanziari unita al potere spropositato degli azionisti nelle imprese o nelle aziende. Le due cose sono collegate ma creano un meccanismo perverso. Come? Gli azionisti comprano le azioni di una azienda e ottengono un potere in genere pari al loro pacchetto di azioni. Tuttavia in molte aziende gli azionisti detengono una maggioranza di azioni rispetto agli "stakeholders". Gli stakeholders sono coloro che hanno un interesse diretto nell'azienda: o ci lavorano (gli impiegati), o sono i direttori e i manager, o sono fornitori dell'azienda. Il benessere degli stakeholders dipende dall'azienda: senza l'azienda gli stakeholders non avrebbero lavoro o salario. Gli azionisti, al contrario, sono solo preoccupati di estrarre il maggior profitto possibile dalle azioni che hanno comprato: in un mercato finanziario estremamente fluido, gli azionisti possono rivendere le loro azioni in pochi minuti e "scrollarsi di dosso" l'azienda in fretta.
Dunque gli stakeholders dovrebbero avere particolarmente a cuore l'azienda da cui dipende la loro occupazione, e quindi il loro scopo è che l'azienda abbia successo nel lungo termine. Gli azionisti, invece, hanno l'obiettivo di massimizzare il profitto delle loro azioni in tempi brevi. Nonostante queste diverse prospettive, gli azionisti hanno un maggiore potere nel prendere decisioni cruciali per il futuro di molte aziende.
Questo significa che in molte aziende ogni investimento fatto per il lungo termine sia visto come un costo inutile da chi è interessato a fare un profitto veloce. E infatti molte aziende (per es. le case automobilistiche americane) per lunghi periodi hanno smesso completamente di fare investimenti per il futuro. Nessun investimento in ricerca e nuove tecnologie, per esempio. Nessun investimento nella formazione e qualificazione della forza lavoro. Siccome gli azionisti pensano ad un profitto veloce, si spende preferibilmente in marketing e altre attività del genere che servono a "gonfiare" la visibilità di un'azienda, facendo alzare le sue quotazioni in borsa, e favorendo gli azionisti.
Visto che chi detiene il potere degli investimenti sta pensando al breve termine invece che al futuro, non sorprende poi tanto che si senta spesso parlare di un'epoca di stagnazione tecnologica e della conoscenza. Quando i migliori cervelli in circolazione vengono catturati da Google e spendono il loro tempo a inventare metodi per convincere un utente a cliccare su un banner pubblicitario, è chiaro che c'è un grosso problema.
Tutto questo vuol dire che il capitalismo non funziona? Prima di buttare via tutto e magari abbracciare vaghi e fantasiosi ritorni ad un passato bucolico mai esistito, ci penserei un paio di volte.
Infatti, il capitalismo non è sempre stato il capitalismo neoliberista attuale. Nel periodo del dopoguerra, almeno in occidente, il capitalismo aveva contribuito ad una enorme diffusione di ricchezza e opportunità che furono molto più equamente condivise dai diversi strati delle società. Oppure, il capitalismo realizzato nei paesi scandinavi riesce a unire la spinta al profitto e la tutela della proprietà privata con un sistema che ridistribuisce la ricchezza generata in modo molto equo e offre opportunità universalmente. E ancora, il recente emergere di nuovi poli economici, è probabilmente in parte responsabile per la riduzione della povertà estrema nel mondo. Come sostengono alcuni autori, la proprietà privata dei mezzi di produzione e l'incentivo al profitto - i cardini del capitalismo- possono essere usati con successo ed efficacemente per creare prosperità e opportunità per i più, non solo per i pochi.
Il capitalismo può perciò essere usato per creare ricchezza, innovazione e opportunità diffuse se solo si approntano i giusti strumenti politici per far lavorare il capitalismo per l'interesse generale. Uno di questi strumenti politici potrebbe consistere nel limitare il potere degli azionisti in molte aziende. Per esempio, in Svezia certi pacchetti di azioni in una azienda detengano un peso maggiore nelle decisioni, assicurando in questo modo che i fondatori di molte aziende e i loro eredi, detentori di questi pacchetti, mantengano maggiore potere decisionale. Oppure, in Germania rappresentanti dei dipendenti partecipano e hanno potere di voto nelle decisioni che riguardano molte aziende. Queste misure politiche potrebbero garantire investimenti in innovazione e formazione, creando lavoratori competenti difficilmente rimpiazzabili da lavoratori a basso costo in altri paesi, e creando innovazione tecnologica che, tra le altre cose, permetterebbe il superamento di tecnologie inquinanti.
Il capitalismo del resto ha permesso un acceleramento del progresso tecnologico e della qualità di vita enorme negli ultimi secoli. Cercherei perciò di far ri-funzionare il capitalismo prima di pensare di poterne fare a meno. Parafrasando Joseph Stiglitz che parlava di John Maynard Keynes, magari bisogna "salvare il capitalismo dai capitalisti".
Subscribe to:
Comments (Atom)